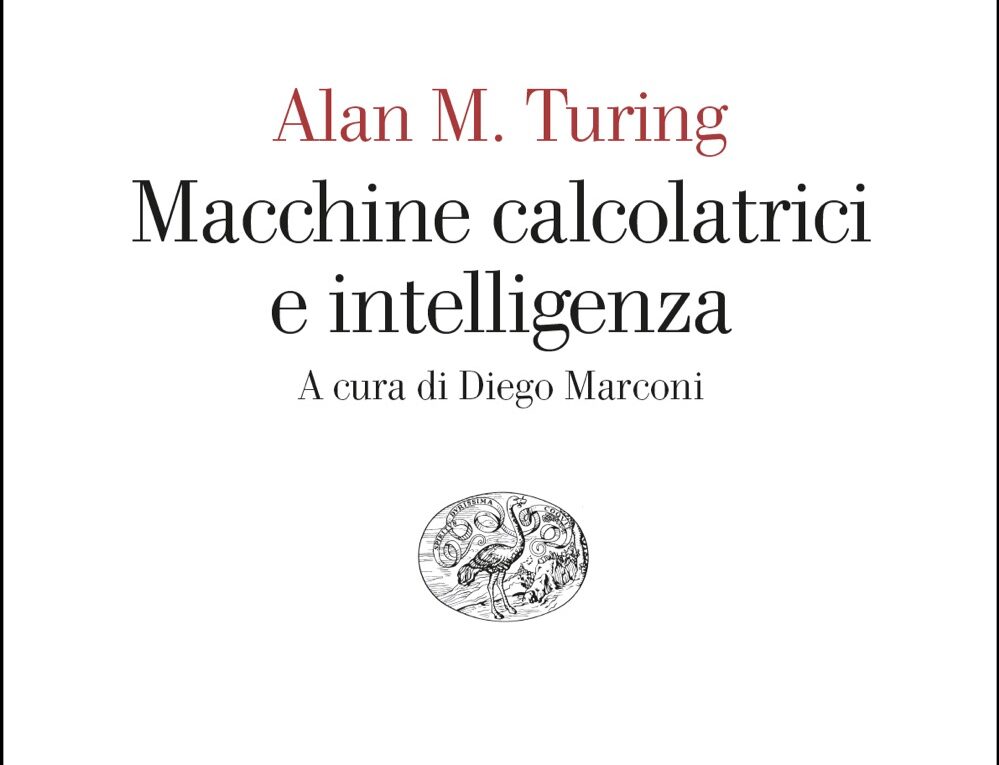Macchine calcolatrici e intelligenza
Alan M. Turing, «Macchine calcolatrici e intelligenza», Giulio Einaudi editore 2025.
In quest’epoca segnata dalla pervasività dell’Intelligenza Artificiale e delle sue declinazioni generative – tra le applicazioni più diffuse citiamo solo gli “assistenti” ChatGP di OpenAI, Gemini di Google e Copilot di Microsoft – riveste un certo fascino la riproposizione del saggio di Alan M. Turing pubblicato nell’ottobre del 1950 e titolato Macchine calcolatrici e intelligenza, apparso in origine con il titolo Computing Machinery and Intelligence sulla rivista «Mind» (LIX, n. 236, pp. 433-60).
In questa nuova edizione italiana curata da Diego Marconi – docente di Filosofia del Linguaggio all’Università di Torino – il testo di Turing – geniale logico, matematico e filosofo inglese – rinnova il suo segno pregnante, concretizzato in una visione al tempo stesso pragmatica e – in un certo qual modo – visionaria. Nel dipanarsi del suo discorso, articolato in diversi capitoli tematici, Turing pone al centro la questione delle “Opinioni contrarie sulla questione principale” (capitolo 6), dove la “questione principale” è appunto riassunta nella seguente domanda: «Le macchine sono in grado di pensare?».
Tra obiezioni e argomentazioni – dall’Obiezione teologica all’Obiezione matematica, dall’Argomento basato sulla coscienza fino all’Argomento della percezione extrasensoriale – si arriva al capitolo titolato Macchine che imparano, ultima densa tappa di un percorso di riflessione che rimane ancora oggi illuminante.
Come evidenzia lo stesso Marconi nello scritto che accompagna il testo: «L’obiettivo del saggio di Turing è semplice e chiaro: si tratta di rendere plausibile l’idea che una macchina possa pensare, […], macchine le cui prestazioni […] siano difficilmente distinguibili da prestazioni umane […]». Possiamo dire che oggi ci siamo molto vicini. (© Gazzetta di Parma)